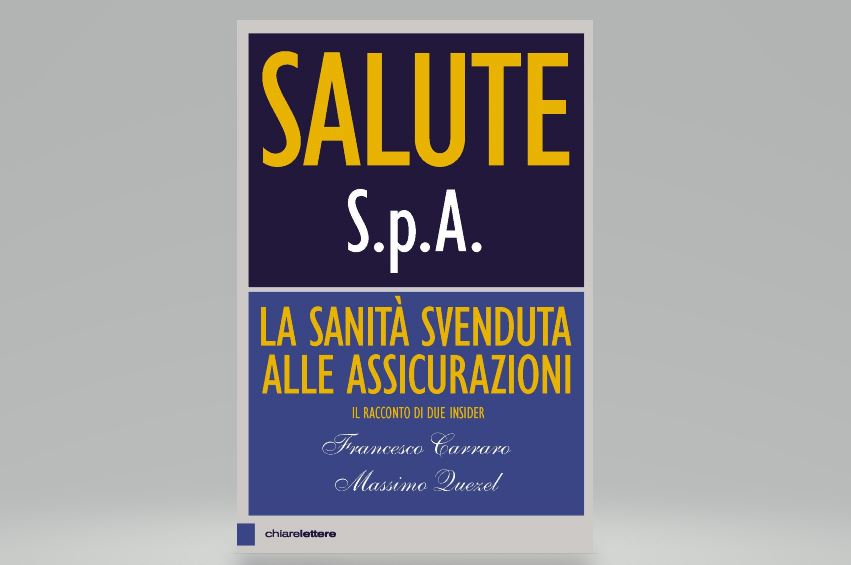2008-2018 Economisti USA litigano sulla crisi
A 10 anni dallo scoppio della crisi mondiale un’aspra polemica tra i maggiori economisti americani riflette il fallimento delle politiche messe in campo dai governi col loro sostegno e l’incapacità di proporre misure alternative. Come emerge dalla polemica però il problema non è trovare una strategia economica efficace, ma vincere la resistenza politica di chi da tale strategia verrebbe danneggiato.
Il 15 settembre il mondo ha celebrato il decennale del crack della Lehman Brothers, l’evento simbolo della crisi finanziaria che nel 2007-2008 ha colpito l’economia mondiale. Le immagini dei colletti bianchi che uscivano dal grattacielo che ospitava la società, scortati dalla sicurezza interna, coi loro scatoloni pieni di effetti personali raccolti in fretta e furia sulle proprie scrivanie, fece il giro del mondo e condensò in pochi fotogrammi la fine di un mondo che solo qualche mese prima sembrava ancora lanciato in una corsa senza fine verso profitti favolosi e destinati a riprodursi altrettanto favolosamente. Una corsa che in qualche misura affondava le proprie radici nella fine della Guerra Fredda, presentataci come viatico di una nuova età dell’oro che avrebbe prodotto pace e benessere diffusi. Sono bastati poco più di 15 anni a lacerare l’involucro propagandistico di quella narrazione, anche se le colpì la Russia e il sud est asiatico, poi con la crisi delle dot com agli inizi del millennio. Dieci anni dopo, mentre la vulgata politica e mediatica dipinge un’economia globale in ripresa gli economisti, una categoria che dovremmo distinguere da quella più in voga dei ‘propagandisti economici’, ci dipingono uno scenari ben diversi, ma allo stesso tempo affondano a loro volta nelle proprie contraddizioni.
E’ proprio vero ad esempio che l’economia americana è uscita dal tunnel grazie alle coraggiose politiche messe in atto da Obama? La vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali sembrerebbe suggerire che molti americani nel tunnel ci si sentano ancora e neppure vedano la luce. E la ragione non sta – come vorrebbero alcuni commentatori – nella loro insipienza, bensì nel modo in cui i benefici della crescita economica americana si sono distribuiti tra le diverse classi della società americana. Il 30 agosto sul New York Times Paul Krugman raccontava che nei giorni precedenti due senatori, Chuck Schumer e Martin Heinrich, erano riusciti a far approvare una legge che impone al Bureau of Economic Analysis di introdurre tra le sue statistiche anche una misurazione di quanta parte della ricchezza dovuta alla crescita dl PIL vada alla middle class (che negli USA significa anche i lavoratori). A conferma – osserva ancora Krugman – che il PIL non è di per sé una misura adeguata del successo di una politica economica. ‘Se Jeff Bezos entra in un bar le entrate medie del proprietario del locale esploderanno immediatamente, ma nessuno degli altri avventori seduti ai tavoli diventerà più ricco’. Aldilà dell’ironia ‘Un tempo chiedersi chi beneficiava della crescita economica non appariva necessario, perché il reddito aumentava costantemente per quasi tutti. Dagli anni ’70 però il legame tra crescita generale e redditi individuali per molti americani sembra essersi spezzato. Da una parte i salari hanno cominciato a ristagnare – il lavoratore maschio medio oggi, al netto dell’inflazione, guadagna meno che nel 1979 – e dall’altro alcuni hanno visto il proprio reddito crescere più rapidamente della ricchezza dell’intera nazione. Gli amministratori delegati delle grandi aziende guadagnano 270 volte lo stipendio medio di un lavoratore, oltre 27 volte più che nel 1980’.
Stiglitz e Soros all’attacco
A partire dalla fine di agosto sull’autorevole sito Project Syndicate si è sviluppata un’ampia e aspra polemica tra alcuni dei maggiori economisti e capitalisti americani, inclusi alcuni consiglieri economici di passate amministrazioni. Il 28 l’ex capo della Banca Mondiale Joseph Stiglitz polemizzava con l’ex consigliere economico di Clinton e Obama, Larry Summers, in un articolo intitolato ‘Il mito della stagnazione secolare’. Nel suo intervento Stiglitz criticava aspramente Summers e in particolare le sue tesi, espresse in un fortunato articolo pubblicato nel 2016 da Foreign Policy e intitolato ‘L’età della stagnazione secolare’ (traduzione italiana qui). Nell’articolo Summers osserva che ‘a quasi 7 anni dalla ripresa dell’economia americana i mercati non si aspettano il ritorno di condizioni “normali” in tempi brevi’ e spiegava questa incapacità di ‘mordere’ dimostrata dalla politica di Obama utilizzando un concetto formulato per la prima volta negli anni ’30 dall’economista Alvin Hansen, la stagnazione secolare appunto. Con questo termine Hansen indica una situazione contraddistinta da un eccesso di propensione al risparmio che determina un forte rallentamento degli investimenti. ‘Il risultato è che l’eccessivo risparmio agisce come un freno ai consumi, comprimendo la crescita e l’inflazione, mentre lo squilibrio tra risparmio e investimenti fa scendere i tassi di interesse reali. Quando si raggiungono livelli di crescita significativi – come è successo negli USA tra il 2003 e il 2007 – ciò deriva da un pericoloso aumento dei prestiti che trasformano l’eccesso di risparmio in un insostenibile livello di investimenti (in quel caso manifestatosi nella forma di una bolla immobiliare)’.
Secondo Stiglitz la stagnazione secolare è una spiegazione difensiva, con cui Summers cerca di mascherare l’eccessiva timidezza di Obama e del suo tema di economisti (lui incluso) nel premere sull’acceleratore delle misure di stimolo all’economia. Stiglitz ricorda che all’epoca lui suggerì un intervento di almeno mille miliardi di dollari e accusa Summers e gli economisti attorno a Obama di avere messo in campo invece una manovra eccessivamente prudente. Secondo Stiglitz la politica di Trump, pur criticabile per molti versi, avrebbe dimostrato invece che chi osa aumentare il deficit alla lunga ottiene dei risultati. ‘L’improvviso aumento del disavanzo statunitense, da circa il 3% a quasi il 6% del PIL, a causa di imposte regressive e mal progettate e di un incremento della spesa bipartisan, ha portato comunque la crescita a circa il 4% e ha ridotto la disoccupazione al livello più basso degli ultimi 18 anni. Queste misure potranno anche essere malconcepite, ma mostrano che con un sufficiente sostegno fiscale, la piena occupazione può essere raggiunta, anche se i tassi di interesse salgono ben al di sopra dello zero’. Stiglitz inoltre accusa le amministrazioni Bush e Clinton (di cui Summers fu anche Segretario al Tesoro) di avere gestito male la globalizzazione, permettendo alle disuguaglianze di esplodere e provocando la debolezza strutturale dell’economia americana alla base della crisi del 2008.
Summers si difende spiegando che la stagnazione secolare più che una scusa per l’insuccesso del team dei consulenti di Obama, è una tesi che rafforza l’idea, condivisa da Stiglitz, che senza un intervento pubblico è impossibile uscire da una recessione profonda. Quanto all’ammontare del pacchetto di stimolo ricorda di avere proposto un intervento da almeno 800 milioni, ma di essersi sentito rispondere che ciò avrebbe prodotto uno shock eccessivo al sistema politico.
Nella polemica contro Summers si inseriscono Rob Johnson e George Soros, lamentando l’occasione persa nel 2009 ‘quando, in risposta alla crisi, il saldo dell’onere del risanamento è stato pesantemente orientato a favore dei creditori rispetto ai debitori, e che questo abbia contribuito alla prolungata stagnazione che ha fatto seguito alla crisi. Le ramificazioni sociali e politiche a lungo termine di questa mancata opportunità sono state profonde’ concludono i due aggiungendo che ‘all’arrivo dell’amministrazione del presidente Barack Obama, uno di noi (Soros) ha fatto appello a Summers per l’adozione di una politica di versamenti di capitali in istituzioni finanziarie fragili e la riduzione dei mutui a un valore di mercato realistico, in modo così da aiutare la ripresa economica. Summers ha obiettato che ciò sarebbe stato politicamente inaccettabile perché avrebbe significato nazionalizzare le banche. Egli asseriva che una politica di tal genere “era in odore” di socialismo e l’America non è un paese socialista’.
L’ottimismo della disperazione
La polemica sulla crisi americana viene spostata da un altro autorevole economista, Kenneth Rogoff, a quella europea in una recensione che egli dedica a Crash, il saggio pubblicato di recente dallo storico Adam Tooze e dedicato alla crisi finanziaria globale. Secondo Rogoff il saggio di Tooze incarna una critica diffusa ma troppo severa alla strategia di risposta fiscale alla crisi (meno tasse e quindi meno spesa pubblica) adottata da quasi tutti i governi dopo il 2008. Pur ammettendo di essere stato favorevole alla cancellazione del debito della Grecia e di altri paesi europei come Portogallo, Irlanda e Spagna, Rogoff afferma che le misure adottate nei confronti di Atene sono state molto più leggere di quelle adottate in situazioni analoghe (ad esempio coi paesi del sud est asiatico), fa dell’ironia sui colleghi Stiglitz e Krugman, che nel 2015 appoggiarono Tsipras e il suo ‘colorato e smart‘ Ministro delle Finanze Yanis Varoufakis e dice di comprendere le ragioni dell’atteggiamento tedesco. ‘Cancellare il debito greco avrebbe implicato una ricapitalizzazione delle banche e tedesche (e francesi) e il costo si sarebbe moltiplicato diverse volte se agli altri debitori del bacino meridionale del Mediterraneo fosse stato praticato lo stesso trattamento. Il debito pubblico tedesco sarebbe potuto crescere del 20%-40% – una strada percorribile ma anche difficile da giustificare. Sebbene personalmente io abbia sollecitato tale strategia, non mi sento di demonizzare i tedeschi per non averlo fatto’. Per Rogoff il vero problema all’origine della crisi europea sta semmai nell’aver messo l’unione monetaria prima di quella fiscale e politica e di avere fatto dell’UE una ‘casa costruita a metà’ (come se unificare il fisco tedesco con quello italiano, coi suoi 100 miliardi di evasione l’anno e il 13% del PIL sommerso, fosse cosa semplice).
L’economista americano tuttavia introduce nel suo ragionamento un argomento che vale la pena di approfondire, cioè l’eccesso di ottimismo degli esperti e delle stesse istituzioni finanziarie in questi 10 anni. ‘Durante la crisi la maggior parte dei governanti si è basata su previsioni caratterizzate da un estremo eccesso di ottimismo, suggerito non solo dai loro consiglieri ma anche in modo particolare da tutti gli esperti esterni. 10 anni dopo ormai tutti concordano sul fatto che le recessioni associate a crisi finanziarie tendono a essere estremamente profonde e con una ripresa molto lenta’. E ricorda che ‘Dal 2009-2010 e in seguito, le maggiori banche centrali del mondo, il FMI, la Banca Mondiale e la maggior parte delle società private hanno dato per acquisito che una rapida ripresa fosse dietro l’angolo’.
Anche Rogoff poi tenta di collocarsi fuori dalla cerchia dei colpevoli: ‘Nel frattempo le proposte di cancellazione del debito per i detentori a basso reddito di mutui subprime ricevevano un‘accoglienza abbastanza calorosa, e mi riferisco anche al libro del presidente Bill Clinton, Back to Work, dove egli citava il mio appello all’annullamento di tali debiti. Ma, di nuovo, i politici si dimostrarono riluttanti ad adottare misure radicali che avrebbero avuto un costo politico e magari incentivato la propensione al rischio (…) Per quanto riguarda la situazione in Europa è stata molto simile. Dal 2010 in poi io e altri suggerimmo che l’eurozona doveva azzerare i debiti di Portogallo, Irlanda, Grecia e, forse, anche Spagna. E ancora una volta sia il FMI sia la Commissione Europea produssero previsioni rosee per la Grecia, che, come abbiamo visto tutti, in realtà lasciarono il posto a un massiccio e prolungato collasso della produzione. I politici insomma non sono stati capaci di intraprendere scelte radicali quando ne avevano l’occasione, perché veniva detto loro di andare avanti così da previsori economici che semplicemente non potevano accettare che le crisi finanziarie potessero amplificare in modo significativo la profondità e la lunghezza delle recessioni’.
La soluzione fiscale non funziona
Insomma 10 anni dopo il crollo di Lehman Brothers pare che tra i maggiori economisti americani si sia aperto non un dibattito franco e improntato a trovare una via di uscita, ma una resa dei conti per scaricarsi vicendevolmente le colpe non solo di una stagnazione che prosegue, ma anche di un nuova crisi che incombe. Il rallentamento imminente dell’economia globale annunciato pochi mesi fa dal World Economici Outlook pubblicato dal FMI viene confermato anche da altre fonti. ‘L’attuale espansione globale probabilmente continuerà l’anno prossimo, dal momento che gli USA si stanno avvalendo di un ampio deficit fiscale, che la Cina sta portando avanti una politica fiscale e monetaria espansiva e che l’Europa rimane sul sentiero della ripresa. Ma dal 2020 matureranno le condizioni per una crisi finanziaria, seguita da una recessione globale’ – scrivono Nouriel Roubini e Brunello Rosa – e secondo i due ci sono almeno 10 ragioni perché ciò avvenga, tra cui il fatto che ‘le politiche di stimolo fiscale che oggi trainano il tasso di crescita americano sopra il suo potenziale 2% sono insostenibili. Dal 2020 lo stimolo avrà termine e un moderato aumento del prelievo fiscale spingerà il tasso di crescita dal 3% ad appena sotto il 2%’.
In conclusione il gotha della scienza e del capitalismo americano si trova, 10 anni dopo, ad ammettere il fallimento delle politiche di questi anni e a cercare di sottrarsi alle proprie responsabilità. Ma ciò che colpisce maggiormente è che la foga nello scaricabarile è tanto più aspra quanto più i protagonisti appaiono incapaci di disegnare vie d’uscita alternative alle misure praticate in questi 10 anni. Appare chiaro infatti che per loro l’unica risposta praticabile è quella delle politiche fiscali e/o monetarie (tipo quantitative easing), che la discussione verte esclusivamente intorno alla misura degli interventi e, infine, che tali politiche però sono insostenibili a lungo andare, perché porterebbero la finanza pubblica alla bancarotta, oltre che in sé contraddittorie.
Rispondere alla recessione con una politica fiscale espansiva significa andare consapevolmente verso il baratro sociale. Nel 2008 un documento del FMI disegnava le linee guida per una rapida uscita dalla crisi: non solo riduzione delle tasse, ma anche aumento della spesa pubblica – non per il welfare e gli investimenti, ma per l’acquisto di beni e servizi sul mercato, quindi soprattutto a beneficio delle imprese – e senza far crescere il deficit: insomma la botte piena e la moglie ubriaca. Il risultato è che le tasse sui ricchi e sulle imprese sono diminuite, facendo diminuire a sua volta il gettito fiscale e costringendo gli Stati a tagliare il welfare e a veder crescere comunque il debito pubblico. Il conseguente ampliarsi delle disuguaglianze ha ulteriormente compresso la spesa delle famiglie meno ricche (cioè la stragrande maggioranza) e ha alimentato la spirale recessiva. E anche quando il PIL ha cominciato a dare segnali di ripresa i benefici sono andati, proprio a causa delle maggiori disuguaglianze, a chi ne aveva meno bisogno. Da segnalare che tra gli autori di questo brillante prontuario c’è il nostro Carlo Cottarelli. D’altra parte si tratta del paradosso che affligge anche la politica dell’attuale governo italiano, che di fatto si propone di trasferire ricchezza verso i disoccupati (reddito di cittadinanza), ma allo stesso tempo di far pagare meno tasse ai più ricchi e più tasse ai lavoratori dipendenti (flat tax).
Il problema è politico
Il motivo per cui non emergono alternative alle politiche fiscali – come emerge dai passi che abbiamo riportato – non è economico, bensì politico. Ridurre le diseguaglianze e alleggerire l’onere del risanamento per i debitori spostandolo sui creditori significherebbe sconfinare in una politica ‘socialista’ (nell’accezione estensiva che il termine ha per gli americani, noi diremmo socialdemocratica). Ma ogni volta che un economista accenna alla necessità di una redistribuzione della ricchezza verso il basso si trova immediatamente di fronte a una risposta di tipo politico e propagandistico, sorretta da previsioni formulate dagli ‘esperti’ e che finiscono regolarmente per rivelarsi infondate. Senza un consistente travaso di ricchezza dai profitti ai salari e al welfare continueremo ad affrontare crisi cicliche, probabilmente sempre più ravvicinate e profonde: è questa la verità che traspare dal dibattito tra gli economisti. Ma questa redistribuzione incontra un’opposizione che non può essere piegata dalla discussione accademica, ma piuttosto dalla reazione di chi in questi anni ha visto il proprio reddito abbattersi. Una reazione che sarebbe tanto più efficace quanto più scegliesse di non isolarsi in una prospettiva esclusivamente nazionale, ma di avere un orizzonte il più possibile globale.
Korn Ferry: 10 anni di stagnazione dei salari
Una ricerca di Korn Ferry conferma che dal 2008 anche i salari dei lavoratori più qualificati sono scesi e che la ripresa economica non ha interrotto questo trend.
Una ricerca realizzata da due analisti di Korn Ferry, Cynthia Stuckey e Benjamin Frost, e di cui la società di consulenza ha dato notizia il 19 settembre, ha analizzato l’andamento dei salari nelle maggiori economie del mondo dall’inizio della cisi del 2008 a oggi. Il risultato è che mentre i mercati e molti settori dell’economia da tempo sperimentano una ripresa i salati reali (cioè le retribuzioni nominali al netto dell’inflazione) continuano a segnare il passo.
Secondo lo studio di Korn Ferry complessivamente i lavoratori qualificati all’inizio della carriera, quelli in una fase intermedia e i dirigenti oggi, tenendo conto dell’inflazione, guadagnano meno che nel 2008. La ricerca ha preso in considerazione 19 economie in tutto il mondo, concentrandosi in particolare queste tre categorie. E ne ha ricavato che se i salari calcolati in dollari sono cresciuti, gran parte degli aumenti sono stati compensati dalla crescita dell’inflazione.
‘Il fenomeno della stagnazione dei salari è davvero globale’ – spiega Ben Frost, uno dei due autori. I dati ovviamente non tengono conto di altre forme di retribuzioni come le stock options. In realtà i più colpiti sono i lavoratori a inizio carriera, quelli con le retribuzioni più basse. Negli USA chi nel 2008 guadagnava 100 dollari oggi guadagna l’equivalente di 84 dollari, una sforbiciata del 16%. In altri paesi per questa categoria di lavoratori le cose vanno anche peggio. I lavoratori brasiliani negli ultimi 10 anni hanno perso il 22% del loro stipendio, gli indiani il 26% e i russi il 28%. Di fatto delle 19 economie prese in considerazione dalla ricerca solo in Cina i lavoratori a inizio carriera oggi guadagnano più di 10 anni fa, anche prendendo in considerazione il valore del salario deflazionato.

Figura 1: variazione dei salari 2008-2018 (ingresso, metà carriera, dirigenti)
I lavoratori a metà carriera invece perlopiù sopravvivono. In 8 paesi hanno un salario reale più alto che 10 anni fa, mentre in 11 guadagnano leggermente meno. I lavoratori americani qualificati a metà carriera oggi guadagnano un 2% più che nel 2008.
Per quanto riguarda i dirigenti invece, tranne poche poche eccezioni hanno visto salire i propri compensi. In 13 su 19 paesi possiamo osservare un aumento reale dei salari. In Cina i dirigenti ottengono addirittura aumenti del 13% dal 2008. I loro colleghi americani si devono ‘accontentare’ del 7%. La ragione di questi aumenti è che c’è ancora scarsità di talenti di alto livello, osserva Frost. Tuttavia la discesa dei salari reali in 6 paesi – Turchia, Russia, Indonesia, Italia, Argentina e Brasile – ha influenzato il dato medio nel suo complesso facendo scendere i compensi anche dei dirigenti. Si tratta di paese che dal 2008 hanno vissuto profondi mutamenti politici e/o crisi economica.
Il grande interrogativo è se questa fase di stagnazione durerà o meno. Secondo Frost no, perché ‘siamo vicini alla piena occupazione e sta diventano difficile coprire un posto vacante, per cui è inevitabile che i compensi ricomincino a crescere’. Ovviamente stiamo parlando soltanto di posti di lavoratori con un’alta qualifica professionale. Ma il dato interessante è che in questi 10 anni neppure loro sono stati risparmiati.
SALUTE SPA In un libro le insidie della sanità integrativa
Non ci sono solo i fondi pensione, di cui ci eravamo occupati ad aprile, nel nuovo business del welfare aziendale. I tagli al pubblico e la contrattazione nazionale spingono sempre più anche i lavoratori nelle braccia dei fondi integrativi. Ne parliamo con Massimo Quezel e Francesco Carraro, autori di un volume sull’argomento appena uscito in libreria.
Ad aprile PuntoCritico si era occupato del cosiddetto welfare contrattuale, previdenza e sanità integrative, ma anche altri pacchetti di prestazioni e servizi offerti da fondi di categoria e compagnie assicurative ai lavoratori di un’area contrattuale, talvolta di una singola azienda o di un territorio come effetto della contrattazione nazionale o aziendale e sempre più spesso come forma di salario indiretto. L’azienda ti paga il premio di produzione facendo un versamento al fondo pensioni di categoria e così facendo risparmia sul costo del lavoro perché beneficia di esenzioni e agevolazioni fiscali, le assicurazioni entrano in un mercato che finora stenta a decollare, il sindacato si trasforma progressivamente in sindacato dei servizi e gestore del welfare, ricavandone anch’esso dei benefici, ma il lavoratore che sempre più spesso viene iscritto forzosamente a un fondo previdenziale o sanitario attraverso la cosiddetta ‘adesione contrattuale’? Ad aprile ci eravamo concentrati in particolare sulla previdenza integrativa e avevamo concluso che se alcune fasce di lavoro dipendente potrebbero ricavarne un piccolo utile economico, in generale non vale la candela.
L’uscita del volume Salute Spa. La sanità svenduta alle assicurazioni. Il racconto di due insider (Chiarelettere), in libreria dal 13 settembre, ci fornisce l’occasione per occuparci più a fondo del capitolo relativo ai fondi sanitari di categoria. Ne parliamo con gli autori Massimo Quezel e Francesco Carraro, i due insider appunto (il primo è patrocinatore stragiudiziale, il secondo avvocato).
Secondo la CGIL gli iscritti ai fondi sanitari contrattuali in Italia sono oltre 6 milioni, mentre si arriva a più di 9 milioni se si considerano anche fondi extracontrattuali: ne esistono di vari tipi – aziendali, territoriali ecc. Sempre secondo la CGIL, che cita uno studio del 2016, questi fondi sottraggono 15,5 e 2,6 miliardi all’erario, rispettivamente attraverso le agevolazioni fiscali di cui beneficiano le prestazione intermediate e come effetto del pagamento delle prestazioni alla sanità privata invece che al SSN. Denaro – sottolinea Quezel – che se invece andasse andasse a finire nella fiscalità generale e al SSN potrebbe contribuire ad avere una sanità pubblica migliore per tutti.
Potete completare il quadro coi vostri dati?
In Italia la spesa sanitaria ammonta a circa 150 miliardi l’anno. Di questi 113 miliardi rappresentano la quota pubblica e il resto, 37 miliardi, la quota privata. Di tutta la spesa sanitaria privata in Italia solo il 12%-13% viene intermediata da fondi e assicurazioni, il resto è il cosiddetto out of pocket, cioè il cittadini va nella struttura privata e paga la prestazione di tasca sua. Una cifra molto bassa rispetto a paesi non solo come gli USA, dove siamo al 76% di spesa intermediata, ma anche come la Francia, dove siamo al 65% e la Germania, dove siamo al 43%. Quindi ci troviamo anche in questo caso, come con la previdenza, in un settore che stenta a decollare. La contrattazione – come sottolineate voi – è uno degli strumenti con cui si cerca di porre rimedio. Nel libro parliamo del contratto integrativo di Poste Italiane, che viene usato per fare in modo che i dipendenti si iscrivano a un fondo sanitario.
E possiamo dire anche che alla riduzione del finanziamento alla sanità pubblica corrisponde una crescita della sanità privata?
Assolutamente sì. Tanto più che in Italia i dati sul finanziamento alla sanità pubblica sono clamorosi. Mentre dal 2000 al 2008, quindi prima della crisi finanziaria, il finanziamento alla sanità pubblica era cresciuto del 14%, negli 8 anni successivi la spesa è aumentata solo dello 0,6%. Mentre la spesa in sanità privata nel quinquennio 2013-2017 è cresciuta del 9,3%. Il risultato è stato sottolineato qualche giorno fa dal Ministro della Salute Giulia Grillo e cioè che la quota di spesa sanitaria che il cittadino è costretto a pagare di tasca sua è ormai giunta al 25%. Mentre gli studi ci dicono che quando si supera il 15% c’è il rischio che la gente finisca per non curarsi, che poi è proprio quello che sta succedendo.
Come funzionano i contratti tra il fondo e l’assicurazione e quanto costano, cioè quanta parte di ciò che versa l’iscritto va all’assicurazione?
Uno dei problemi da prendere in considerazione rispetto alla sanità integrativa è quanto essa si comporta da fondo e quanto da assicurazione. Perché un’assicurazione ha una vocazione al business, è una società di capitali che opera per fare profitto, mentre un fondo dovrebbe avere una vocazione di carattere mutualistico. Secondo alcune fonti in Italia il rapporto è 50-50, ma secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità siamo a un 65% di spesa sanitaria intermediata da polizze assicurative. Poi per capire quanta parte di ciò che versa un lavoratore va a finire in profitto della compagnia assicurativa bisognerebbe chiederlo alla compagni assicurativa. Io ho trovato pubblicazioni che parlavano di un 40%, che mi sembra tanto. Ma ovviamente bisognerebbe fare un’indagine accurata.
Per quanto riguarda la previdenza Beppe Scienza dice che in generale non conviene, ma conviene a chi guadagna di più e ha più anzianità? Avete fatto delle simulazioni? Si possono fare? Situazioni con parametri analoghi: quanto spendo col SSN e quanto con la mutua integrativa?
Guarda, in base a tutte le interviste che abbiamo fatto possiamo dire che in termini di spesa per il cittadino la scelta migliore è sempre il pubblico. Il privato ti può dare di più sulle prestazioni di contorno, ad esempio sul servizio, sulla qualità delle stanze ecc. In Veneto il governatore Zaia ad esempio ha introdotto una pratica interessante, cioè il cittadino riceve la prestazione e nel certificati di dimissione viene informato di quanto è costata al SSN, anche se lui non la paga. D’altra parte il problema è che la scelta spesso non è libera. Nelle interviste che abbiamo fatto la chiave di volta è la visita specialistica o l’esame diagnostico. Nel pubblico sono le liste di attesa che speso spingono il cittadino verso la struttura privata.
Poi c’è la copertura che varia e copre di più quanto più si spende, giusto? Ci segnalano casi in cui il rimborso viene negato senza dare spiegazioni. Come difendersi? Ci sono molti contenziosi?
Contenziosi ce ne sono parecchi e spesso capita anche che una prestazione non venga rimborsata perché non è previsto dal contratto o perché c’è una franchigia al di sotto della quale non c’è rimborso. L’impressione che spesso emerge dalle interviste è che i contratti voluminosissimi possano essere studiati proprio per prestarsi alle eccezioni. La soluzione potrebbe essere quella di introdurre un tipo di contratto per cui vengono rimborsate tutte le prestazioni tranne quelle che sono espressamente escluse.
Passiamo a un bilancio più generale. Nel libro voi dite sostanzialmente che le assicurazioni stano cercando di uscire dal mercato dalle polizze RC fatte alla sanità pubblica, che non sono più remunerative, a quello della sanità integrativa per i singoli cittadini.
Sì, in alcuni documenti ufficiali delle assicurazioni viene detto espressamente che il mercato delle polizze con cui le strutture pubbliche si coprono dal rischio di eventuali errori non è più redditizio, perché i cittadini sono più attenti ai propri diritti e anche i giudici sono più sensibili ai diritti dei pazienti, per cui alla fine i risarcimenti che le compagnie sono costrette a pagare sono bassi rispetto ai premi che incassano dalla sanità pubblica. In altre parole quello – dicono le assicurazioni – è un mercato che sta andando fuori controllo, un po’ come i derivati. Ma la questione centrale che affrontiamo nel libro è che nel momento in cui i professionisti del rischio si apprestano a uscire da questo mercato, la sanità pubblica, che non ha alcuna competenza in materia, invece di entra con l’introduzione della pratica dell’autoassicurazione.
Potete spiegarvi meglio?
L’anno scorso il Parlamento ha approvato a larghissima maggioranza, con l’astensione di Lega e M5S, una legge con primo firmatario il deputato del PD Federico Gelli, che permette alle singole strutture pubbliche di scegliere se stipulare una polizza oppure ‘autoassicurarsi’ risarcendo direttamente eventuali danni. E’ come se tu dicessi a un automobilista che può decidere di non pagare più la RC auto. Significa risparmiare molti soldi, ma se poi provochi un incidente? Noi abbiamo chiesto a un gruppo di statistici di fare una proiezione che riguarda la Regione Toscana, la prima che ha scelto di adottare l’autoassicurazione. Abbiamo chiesto loro di calcolare quanto potrebbe pagare la sanità toscana una volta che essa vada a regime. Il risultato è che pagherebbe circa 80 milioni di euro l’anno, invece di premi assicurativi per 52 milioni l’anno.
Avete toccato l’argomento della politica, che nel vostro libro ne esce male e appare completamente subalterna al potere delle assicurazioni, a prescindere dal colore di chi sta al governo.
Se ti leggi la normativa in materia RC auto e sanità dal 2000 a oggi potrai constatate che ogni atto legislativo approvato non fa che ridurre i diritti dei cittadini a tutto beneficio delle compagnie assicurative.
E quali sono le compagnie che controllano il mercato della sanità integrativa?
Le due maggiori compagnie sono quelle di Generali e Unipol, che stipulano rispettivamente polizze per circa 600 e 550 milioni di euro l’anno.
C’è però un problema di malasanità.
Sì, ma è un circolo vizioso alimentato dalla politica. Io taglio i fondi alla sanità pubblica, così le prestazioni peggiorano e a quel punto io, invece di investire di più per invertire la tendenza, tagli ulteriormente e spingo i cittadini nella braccia delle assicurazioni. E’ vero – come sottolineano i centri studi della assicurazioni – che c’è una massa di italiani, l’equivalente di un partito politico del 25%-30%, che è insoddisfatta o arrabbiata nei confronti della sanità pubblica. Detto questo ci sono due soluzioni: una è quella di affidarsi alle compagnie assicurative, l’altra, che è alla base del nostro libro, è quella di tornare a investire su pubblico per avere una sanità migliore accessibile a tutti.

LOMBARDIA Epidemia ‘unica al mondo’ ignorata
Un’epidemia di legionella ‘unica al mondo’ in Lombardia uccide 4 persone in poche settimane, secondo l’ISS le regole per la prevenzione vengono disattese, ma la politica non se ne occupa. Mentre i 4 morti di morbillo nel 2017 infiammano da due anni la polemica sui vaccini. Un evidente paradosso, che rischia di rafforzare il consenso di chi è contrario ai vaccini per principio.
Mentre riprende la polemica sui vaccini, favorita anche dagli stop and go impressi dal Governo ai provvedimenti in materia, in Lombardia sta avvenendo qualcosa a cui l’informazione non sembra fare altrettanto caso. La parte meridionale della provincia di Brescia, quella settentrionale della provincia di Mantova e, in misura minore, il monzese sono interessati da luglio da ‘un’epidemia unica al mondo di legionella’ (sono parole dell’Istituto Superiore di Sanità). Anche se pare che la curva epidemica si stia abbassando dai primi del mese sono 400 i colpiti da polmonite, di cui 200 ancora ricoverati nella bassa bresciana e nell’alto mantovano e 3 finora i morti. L’ultima ondata di contagi, 23 ricoveri, risale a lunedì.
La Legionellosi, detta anche Malattia dei legionari, è un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila. È stata identificata per la prima volta nel 1976, a seguito di una grave epidemia (221 persone contrassero questa forma di polmonite precedentemente non conosciuta e 34 furono i decessi) avvenuta in un gruppo di ex combattenti dell’American Legion (da qui il nome della malattia), che avevano partecipato ad una conferenza in un Hotel di Philadelphia, negli Stati Uniti. La fonte di contaminazione batterica fu identificata nel sistema di aria condizionata dell’albergo.
La legionella è un batterio presente negli ambienti naturali e artificiali: acque sorgive, comprese quelle termali, fiumi, laghi, fanghi, ecc. Da qui essa raggiunge quelli artificiali come condotte cittadine e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e piscine, che possono agire come amplificatori e disseminatori del microrganismo, creando una potenziale situazione di rischio per la salute umana.
In Lombardia, a parte qualche esponente della Lega che ha voluto ricondurla alla ‘invasione’ di migranti dal nord Africa, pare che la causa del contagio risieda nelle torri di raffreddamento di alcuni impianti industriali del bresciano, da cui il batterio potrebbe essersi propagato per chilometri grazie al vento e ai temporali. L’ipotesi dell’ISS è che la fonte del contagio sia unica e si sia propagata per nebulizzazione. Il batterio è stato trovato nella doccia di un pensionato morto qualche giorno fa a Carpenedolo. Si tenga presente che la malattia si trasmette non bevendo acqua contaminata ma inalando particelle di acqua infette nebulizzate appunto nell’ambiente.
In Italia la diffusione della legionella, che si manifesta con polmonite (con un 10%-15% di decessi) o febbre, è in forte crescita: siamo passati dalle 1570 diagnosi del 2015 ai 1700 casi del 2016 ai quasi 2mila del 2018, un aumento del 17% in un solo anno. Non a caso nel maggio del 2015 la conferenza Stato-regioni ha approvato le linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, che però vengono spesso disattese. Ad affermarlo al Sole24Ore250718 è Maria Luisa Ricci, ricercatrice che si occupa proprio di legionella per contro dell’ISS. Il risultato è che l’epidemia in Lombardia, pur di portata superiore alla media, non è un caso isolato. ‘Già in passato abbiamo avuto in Italia eventi epidemici: a Parma nel 2016 ci sono stati 42 casi, legati alle torri di raffreddamento dell’ufficio postale, a ridosso dell’epicentro dell’epidemia. E dal 2005 al 2008 tantissimi casi a Cesano Maderno, in provincia di Monza, la cui origine è rimasta sconosciuta. (…) E poi abbiamo avuto un’altra importante epidemia a Roma nel 2003 con 15 casi e in questo caso la causa è stata la torre di raffreddamento di un grande edificio commerciale’. Si tratterebbe dunque di un problema causato perlopiù da carenze imputabili al mondo dell’impresa con un impatto sanitario (e finanziario) sulla sanità pubblica.
Si tratta di numeri contenuti e tali da non suscitare allarmi rossi e tuttavia colpisce la sproporzione tra la scarsa attenzione dedicata questa notizia e il peso assunto negli ultimi anni dal dibattito su malattie come il morbillo, nel quadro della polemica sui vaccini. Una sproporzione non giustificata dai numeri. In Italia secondo l’UNICEF nel 2017 si sono verificati circa 4700 casi di morbillo e 4 decessi, mentre per quanto riguarda la legionella abbiamo visto che siamo a circa 2mila e 4 decessi si sono verificati solo in queste ultime settimane. E’ un paradosso che pesa sulla sanità pubblica e sulla politica che governa il sistema sanitario nazionale e che rischia di radicalizzare posizioni di rifiuto ‘a prescindere’ dei vaccini e di altre conquiste della moderna medicina. D’altra parte il dubbio che ben altro spazio sarebbe stato dedicato all’epidemia lombarda se esistesse un vaccino per la legionella appare più che legittimo.